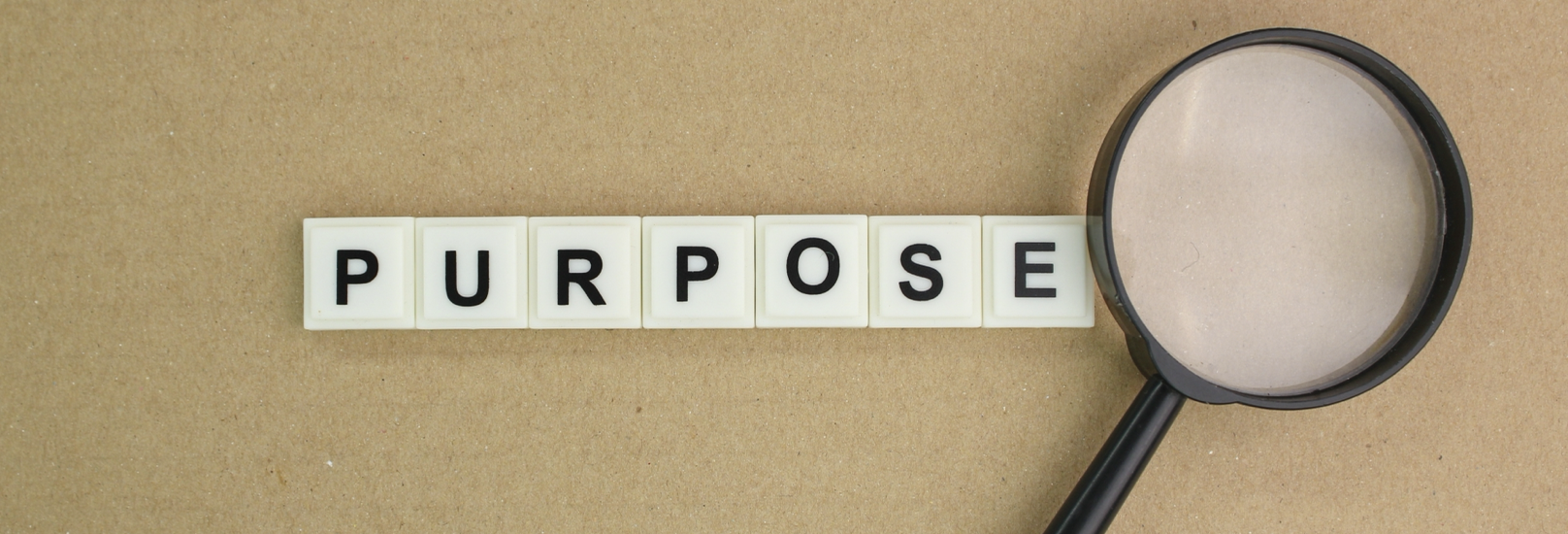Digital Strategy / Employer Branding
Per innovare ci vuole coraggio
5 lezioni dai Nobel per l’economia 2025, per aver spiegato la crescita economica sostenuta dall’innovazione. C'entrano il coraggio e le capacità, ovviamente.
DI Francesca Fantini / novembre 2025
Sono cresciuta pensando che la crescita economica fosse una legge di natura. Ma guardandoci indietro possiamo dire che per migliaia di anni non siamo cresciuti affatto. Eravamo bloccati in un loop di stagnazione.
Come ne siamo usciti? Come abbiamo innescato la prosperità in cui molti di noi vivono?
Un contributo interessante arriva dai vincitori del Nobel per l’economia 2025: Mokyr, Aghion e Howitt, che mettono in relazione l'innovazione e la crescita economica.
Un tema tanto rilevante quanto attuale, per le imprese che vogliono prosperare.
Ecco cinque lezioni che possiamo imparare per crescere - e lavorare - meglio.
1. Il progresso parte dalle idee e non dalle tecnologie
Ci hanno raccontato che la Rivoluzione Industriale è iniziata grazie al carbone o alla macchina a vapore. Sbagliato: è partita da un cambiamento di mentalità.
Joel Mokyr (premio Nobel 2025 per l'economia insieme a Philippe Aghion e Peter Howitt) lo chiama "illuminismo industriale": la convinzione, all’epoca fortemente inusuale, che il progresso attraverso la conoscenza fosse non solo possibile, ma desiderabile.
Per secoli il sapere scientifico (il “perché” funzionano le cose) e il sapere tecnico (il “come” farle funzionare) hanno vissuto in mondi separati. I filosofi pensavano, gli artigiani facevano.
Il progresso è esploso quando questi due mondi si sono scontrati: la teoria ha iniziato a migliorare la pratica (l’ingegnere che usa la scienza per costruire un motore migliore), e la pratica ha iniziato a sfidare la teoria.
Ma le idee, ci avverte Mokyr, non bastano. Serviva una società disposta ad accettarle e a farle circolare, senza che la lobby dei cocchieri bloccasse l’invenzione dell’automobile per paura di perdere il lavoro.
Suona familiare? È la nostra esatta situazione attuale: una rivoluzione tecnologica (l’AI) frenata da un certo tipo di cultura aziendale (il management, il controllo, il "si è sempre fatto così") che resiste disperatamente al cambiamento.

2. La prosperità crea e distrugge
Se Mokyr ha trovato il carburante, Aghion e Howitt hanno mappato il motore, che si basa su un’idea di Schumpeter: la "distruzione creatrice".
Di solito pensiamo al progresso come a qualcosa di gentile, un accumulo pacifico di benessere. Anche questa è una convinzione errata.
È Netflix che fa fallire Blockbuster. È l'auto che distrugge il mercato delle carrozze. È l’email che rende obsoleto il fax.
La crescita stabile che vediamo a livello macro (il PIL) è alimentata da un caos costante a livello micro (aziende che falliscono, persone che perdono il lavoro).
E perché mai qualcuno dovrebbe innovare, sapendo di essere la prossima vittima? Semplice: per il premio. La possibilità di ottenere un monopolio temporaneo e profitti enormi. È un gioco spietato in cui chi vince si prende tutto. Fino al prossimo sfidante.
È lo stesso meccanismo che definisce la creator economy o il mercato dell’AI: il vincitore (Nvidia, OpenAI) non si prende una fetta di mercato, si prende tutto. Fino alla prossima rivoluzione del progresso.
3. Il libero mercato da solo non basta
Ecco un altro mito che crolla. L’idea che “lasciar fare al mercato” produca magicamente l’innovazione perfetta è una favola per chi non guarda i dati.
Aghion e Howitt dimostrano che il motore, da solo, ci sbatte fuori strada. A volte produce troppo poca innovazione (perché un inventore non viene pagato per il beneficio che la sua idea darà alle generazioni future). Altre volte ne produce troppa (aziende che spendono miliardi in Ricerca e Sviluppo solo per rubare una fetta di mercato, con un costo sociale enorme).
Per questo servono regole. Servono politiche che gestiscano i costi umani della distruzione, come i programmi di flexicurity che supportano chi perde il lavoro: un equilibrio tra flessibilità e sicurezza nel mercato del lavoro, cruciale per gestire le conseguenze sociali dell'innovazione tecnologica. Perché il progresso non va solo “liberato”, va indirizzato.
Oggi abbiamo la distruzione, ma ci manca completamente la security. Parlare di reskilling e upskilling può essere una soluzione?
4. Il capitale umano conta più di tutto
Perché alcuni paesi esplodono e altri no? Non è (solo) una questione di numeri.
I modelli di crescita endogena, sviluppati da Paul Romer e ripresi dai premi Nobel, ci insegnano una lezione fondamentale: la vera “dimensione del mercato” che conta per l'innovazione non è il numero di persone disponibili sulla piazza, ma la quantità di capitale umano, ovvero l'insieme di competenze, istruzione ed esperienza. Come ha sottolineato Romer, è “lo stock di capitale umano a determinare il tasso di crescita” e “avere una vasta popolazione non è sufficiente a generare crescita”.
Romer distingue tra due tipi di risorse. Il capitale umano (H) è una risorsa definita “rivale”, legata a una persona specifica: un ingegnere non può essere in due posti contemporaneamente. La tecnologia (A), invece, è un’idea, un progetto, ed è una risorsa definita “non-rivale”: un software può essere copiato all’infinito a costo quasi nullo. Il capitale umano è la “fabbrica” (H) che produce i “progetti” infinitamente replicabili (A) che guidano il progresso.
Questa intuizione spiega perché paesi molto popolosi come Cina e India traggano enormi benefici dall’integrazione nei mercati mondiali. Non si tratta solo di accedere a più consumatori, ma di connettersi a un bacino globale più vasto di capitale umano (H) per generare più conoscenza tecnologica (A) a beneficio di tutti.
In poche parole, è il capitale umano che genera il progresso.
L'AI potrebbe sfidare questa idea. Un agente AI che sa programmare o progettare non è più una risorsa "rivale" e scarsa come un ingegnere umano. È una risorsa "non-rivale", proprio come un software: puoi copiarla un milione di volte a costo quasi zero.
E allora, dove si sposta il valore?
Se la "fabbrica" stessa — la capacità di eseguire compiti specializzati — diventa una commodity abbondante e a basso costo, il suo valore crolla. Il valore non sparisce, però: semplicemente si sposta più in alto.
Si sposta dall'esecuzione all'orchestrazione.
In poche parole: sarà più di valore saper definire e circoscrivere un problema, avere visione, decidere cosa va fatto, e poi orchestrare gli agenti IA per farlo al meglio.
Il collasso del valore della competenza tecnica è una minaccia solo per chi si ostina a identificarsi con quella. Per tutti gli altri, è una liberazione. Ci costringe a smettere di essere ingranaggi iperspecializzati e a diventare architetti nel senso più ampio del termine.

5. Il PIL non è l'unica metrica della crescita
Sebbene la crescita di un Paese sia misurata in termini di Prodotto Interno Lordo (PIL), il lavoro dei tre Nobel ci ricorda che il vero impatto dell’innovazione va ben oltre i numeri. Molti dei benefici più rivoluzionari sulla qualità della vita, infatti, spesso non vengono catturati dalle metriche economiche.
Negli ultimi due secoli, la "distruzione creatrice" ha trasformato ogni aspetto della nostra esistenza in modi che diamo per scontati:
- migliore assistenza sanitaria, grazie a nuovi farmaci e tecnologie mediche
- migliori opportunità educative, con un accesso più ampio e di qualità all’istruzione
- più tempo libero, grazie all'aumento di efficienza e produttività
- prodotti migliori e più sicuri: pensiamo alle auto con sistemi di sicurezza avanzati o agli elettrodomestici più moderni
- comunicazione più efficiente, grazie a internet e alla telefonia mobile.
Il messaggio fondamentale che emerge dal lavoro di Mokyr, Aghion e Howitt è che la crescita economica non è una legge di natura. È, al contrario, un “equilibrio fragile” che dipende da una complessa alchimia: una cultura aperta a nuove idee, istituzioni che incentivano l’innovazione e una società disposta a gestire i conflitti che ne derivano.
Il progresso è una scelta culturale: dobbiamo avere il coraggio di prenderci cura di questo fragile equilibrio.
L'ho scritto da sola, questo articolo? Ovviamente no.
Grazie in particolare a:
CHI L’HA SCRITTO?

Nata da un felice connubio tra Italia del nord e del sud, possiede il gene prepotente della curiosità. Copywriter di professione, storyteller per vocazione, vegetariana per scelta, nel tempo libero fa esperimenti ai fornelli e acquista più libri di quanti potrà mai leggerne.