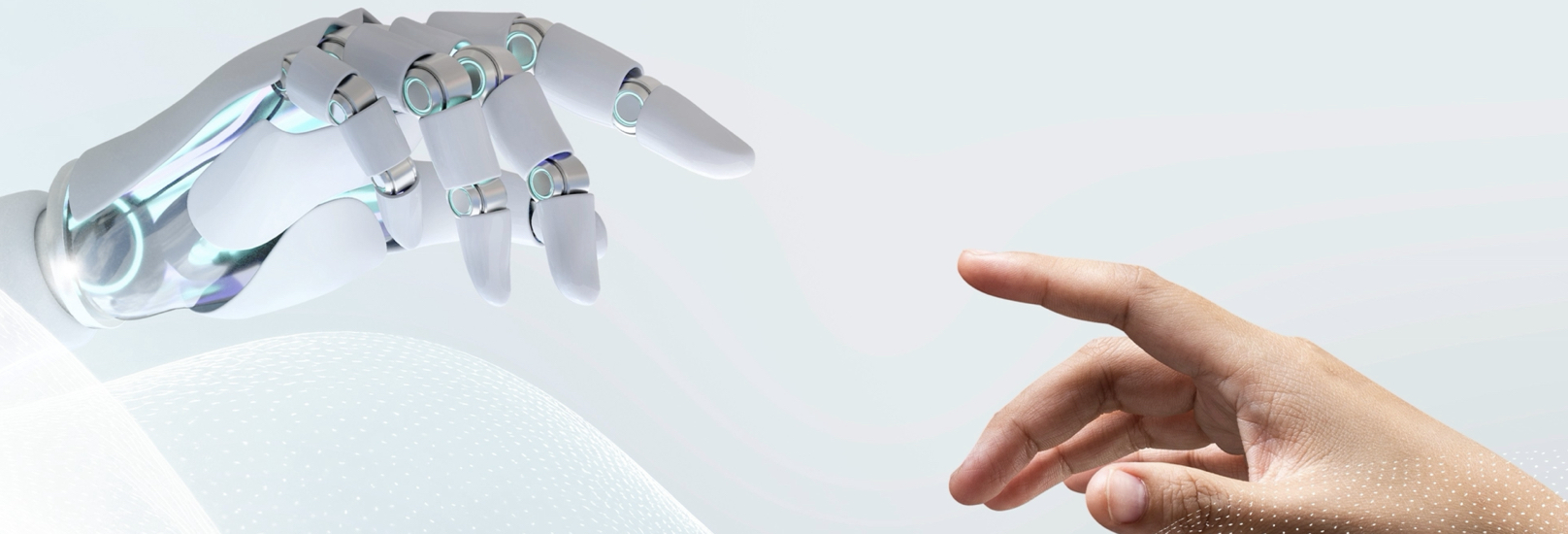Digital Trend / Innovazione digitale
AIpocalittici o AIntegrati? Una lezione di Umberto Eco
Il dibattito tra apocalittici e integrati iniziato da Umberto Eco è più vivo che mai, e oggi verte sull'intelligenza artificiale. Esploriamo le due fazioni.
DI Francesca Fantini / novembre 2025
Ogni volta che spunta una nuova tecnologia, il mondo si spacca in due.
Da un lato, gli apocalittici: quelli che vedono la fine della civiltà, la perdita di posti di lavoro, la morte del pensiero critico. Dall’altro, gli integrati: i tecno-ottimisti che promettono un’utopia di produttività e conoscenza per tutti.
Nel 1964 Umberto Eco pubblicò Apocalittici e integrati. Analizzando la cultura di massa dell’epoca - dai fumetti alla televisione - divise gli intellettuali in due fazioni: chi vedeva nell’industria culturale una barbarie che addormentava le coscienze e chi, al contrario, ne celebrava la capacità di democratizzare il sapere.
Sessant’anni dopo, questa griglia interpretativa si applica con precisione chirurgica al dibattito sull’intelligenza artificiale.
La tecnologia è mutata, ma la polarizzazione emotiva rimane identica, oscurando spesso la comprensione reale dei meccanismi in gioco. Chi sono, dunque, i nuovi apocalittici e integrati, e come andare oltre questa divisione? Parliamone.
1. I nuovi apocalittici: tra bias, perdita di originalità e di posizioni di lavoro
La critica più solida mossa da chi oggi diffida dell’IA (i nuovi apocalittici) riguarda la natura stessa del contenuto generato. Non si tratta solo del timore della disoccupazione, ma del rischio di una produzione culturale dominata dal kitsch.
Secondo la definizione della Treccani, il kitsch si basa sulla "prefabbricazione e imposizione dell’effetto": è una simulazione dell’arte priva di urgenza originale. I Large Language Models (LLM) operano esattamente secondo questo principio. Non creano; riproducono pattern probabilistici basati su ciò che ha già funzionato statisticamente in passato. Il risultato è un flusso di contenuti formalmente corretti ma strutturalmente mediocri e creativamente banali.
Questo meccanismo porta alla mercificazione del lavoro cognitivo. Competenze che fino a ieri potevano richiedere anni di studio - come la stesura di un testo funzionale, la sintesi di documenti o la scrittura di codice base - diventano commodity a costo quasi zero. La minaccia non è necessariamente la scomparsa del lavoro, ma la svalutazione economica di tutto ciò che è standardizzabile.
A tutto ciò si aggiunge il problema tecnico dei bias. Poiché i modelli vengono addestrati su dataset storici, tendono a cristallizzare e amplificare i pregiudizi esistenti (di genere, etnia o altro), restituendoli sotto una patina di neutralità oggettiva.

L'IA segnerà la fine dell'umanità per come la conosciamo?
2. I nuovi integrati: l’utopia della produttività
Chi abbraccia la tecnologia (i nuovi integrati) si concentra invece sul potenziamento delle capacità umane. L'IA non è vista come un sostituto, ma come uno strumento di calcolo avanzato capace di vedere correlazioni invisibili all'occhio umano.
I risultati in campi specifici sono tangibili. AlphaFold di Google DeepMind, per esempio, ha predetto la struttura 3D di quasi tutte le proteine note, risolvendo in pochi anni un problema che ha impegnato i biologi per decenni. In questo scenario, l'IA libera il professionista dalle attività a basso valore aggiunto per concentrarsi sulla strategia e sulla scoperta.
Tuttavia, l'accesso allo strumento non equivale alla competenza. Senza una profonda alfabetizzazione sui dati, si rischia di creare un nuovo divario di classe tra chi usa l'IA come co-pilota critico e chi ne subisce passivamente l'output.

L'IA ci renderà super umani?
3. La lezione di Eco: la cultura come filtro
Per navigare questo scenario, serve recuperare un concetto centrale nell'opera dell'Eco maturo: la funzione della memoria e dell'oblio.
Nel racconto "Funes, o della memoria" di Borges, spesso citato dal semiologo, il protagonista è un uomo incapace di dimenticare. La sua mente è un archivio infinito di dettagli, ma questa "memoria totale" lo paralizza: non può pensare, perché pensare significa scartare, generalizzare, scegliere.
L'Intelligenza Artificiale odierna assomiglia a Funes. Possiede una memoria totale del web, ma manca della capacità intrinseca di distinguere il rilevante dal rumore, il vero dal verosimile. Se deleghiamo interamente all'algoritmo il compito di selezionare le informazioni, accettiamo di vivere in una bolla confortevole dove ogni contenuto è "prefabbricato" per confermare le nostre aspettative.
La soluzione non è rifiutare la tecnologia, né accettarla ciecamente. È applicare un metodo semiotico: interrogare la fonte, analizzare come è stato costruito il modello e capire perché ci sta fornendo quella specifica risposta. La cultura, oggi più che mai, è la capacità di applicare un filtro umano a un flusso infinito di dati artificiali.
Che ne dici, si può fare?
CHI L’HA SCRITTO?

Nata da un felice connubio tra Italia del nord e del sud, possiede il gene prepotente della curiosità. Copywriter di professione, storyteller per vocazione, vegetariana per scelta, nel tempo libero fa esperimenti ai fornelli e acquista più libri di quanti potrà mai leggerne.