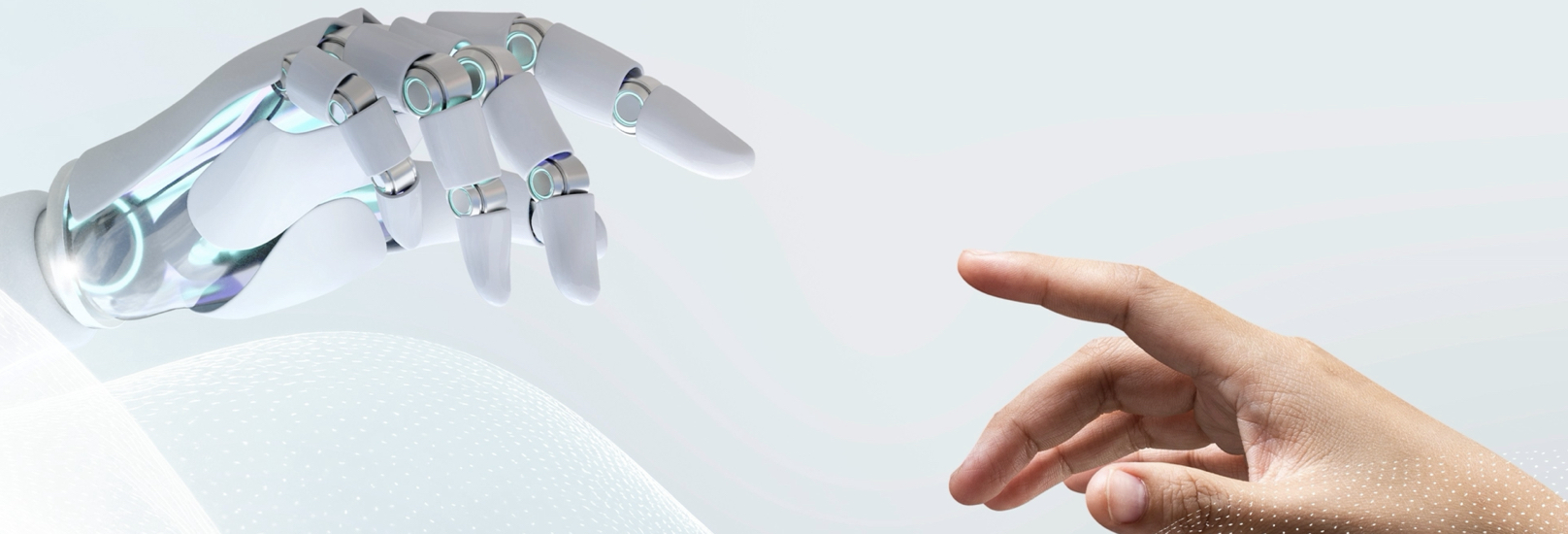Intelligenza Artificiale / Innovazione digitale
Intelligenza artificiale e generalismo naturale
L'intelligenza artificiale potrebbe liberarci dalla specializzazione forzata, permettendoci di tornare alla nostra natura di generalisti. Cioè? Daje, leggi.
DI Francesca Fantini / novembre 2025
L’essere umano, per sua natura, è un generalista. Fin dalle nostre origini, il successo della specie homo sapiens non è dipeso dalla capacità di eccellere in una singola nicchia (come facevano i nostri cugini Neanderthal, a quanto pare), ma dalla nostra incredibile plasticità: la facoltà di adattarci, di integrare conoscenze disparate e di riconfigurare le strategie di sopravvivenza in ambienti radicalmente diversi, dai deserti ai ghiacciai.
Negli ultimi due secoli, però, questa nostra natura è stata compressa. La rivoluzione industriale ha imposto un modello economico basato sulla frammentazione estrema delle competenze, spingendoci verso una specializzazione sempre più verticale. Era il modo migliore per massimizzare l'efficienza delle macchine meccaniche: scomponendo il lavoro in passaggi minimi e ripetitivi.
Questa stagione di specializzazione forzata sembra essere sulla via del tramonto: diamo il benvenuto all’intelligenza artificiale. Possiamo considerare l’era della specializzazione una parentesi che l’IA ci farà chiudere? E dove andremo, poi? Non ho le risposte ma mi piace pensare a questo genere di domande.
1. La frammentazione del lavoro
La logica della frammentazione ha trovato la sua espressione più netta nel taylorismo all’inizio del Novecento.
Chit-chat da fare davanti alla macchinetta del caffè: Frederick Winslow Taylor teorizzò la separazione netta tra chi pensa (i manager) e chi esegue (gli operai), riducendo questi ultimi a meri esecutori di movimenti standardizzati. Olé.
Questa divisione non è rimasta confinata alle catene di montaggio; ha contaminato l’accademia, la medicina e le professioni intellettuali, creando i famosi silos comunicativi e operativi. Questa cosa da un lato ha generato una produttività materiale senza precedenti, dall’altro ha creato una forma di alienazione in cui il lavoratore perdeva la comprensione del tutto per concentrarsi esclusivamente sul dettaglio. Alla grande.
Molti storici ed economisti hanno iniziato a vedere questo modello come una fase nella nostra vita di sapiens, un blip temporaneo necessario per l’aumento della produzione, ma intrinsecamente limitato.
L’IA mi suggerisce un aforisma di Heinlein - uno scrittore di fantascienza - “la specializzazione è per gli insetti”. Noi come esseri umani non siamo bloccati in un unico compito morfologico. Sembra che la nostra forza risieda nella capacità di affrontare contesti diversi con una buona capacità di adattamento. Ce lo siamo dimenticato?

E comunque gli insetti non fanno una brutta vita, dai.
2. L’IA potrebbe liberare la nostra vera natura
L'intelligenza artificiale al momento esternalizza bene i compiti mentali più routinari: calcolo, analisi di pattern, sintesi di grandi quantità di dati e scrittura di codice boilerplate (standard, generalizzato).
Non solo: questa tecnologia abbassa le barriere all’ingresso di complesse competenze di dominio (grafica e testi, tanto per dirne due delle più evidenti. Ciao a voi che lavorate in questi ambiti, la vita è dura, già).
L’IA e i suoi artefatti digitali si fanno carico della lavoro specializzato, verticale, mentre l’uomo può riappropriarsi della sua capacità di pensiero. Un paio di esempi:
- Nella programmazione l’IA permette a un Product Engineer di progettare l’intera architettura di un sistema e di generare il codice necessario, riportando il controllo olistico del manufatto a un’unica figura, senza dipendere da silos di specialisti (frontend, backend, DevOps eccetera).
- Nella medicina l’IA può diagnosticare patologie complesse analizzando simultaneamente immagini, sequenze genetiche e note cliniche. Questo libera il medico dal ruolo di tecnico di riconoscimento pattern, per farlo tornare al ruolo di generalista della cura: un professionista che integra l’output della macchina con la storia biografica, i valori etici e la visione complessiva del paziente.

Le penseur di Rodin, due metri di bronzo muscoloso e pensieroso.
3. Diventiamo architetti di senso?
Mentre l’IA si occupa dell’efficienza e della sintassi (il come), il ruolo esclusivo dell’essere umano rimane la governance e l’infusione di senso (il perché). Dici poco.
L’intelligenza artificiale è eccellente nel manipolare simboli in base alla probabilità statistica (calcolo), ma non possiede comprensione o coscienza o in generale quelle qualità non algoritmiche legate all’esperienza vissuta e alla capacità di dare un significato etico e strategico. Che invece qualcuno di noi possiede.
Il valore umano sembra dunque risiedere nella capacità di porre le domande giuste e di integrare le risposte in una visione strategica coerente. Possiamo, dobbiamo diventare architetti di senso, coloro che decidono quale valore (equità, sostenibilità, profitto) debba guidare l’ottimizzazione fornita dalla macchina. O hai un’idea migliore?
CHI L’HA SCRITTO?

Nata da un felice connubio tra Italia del nord e del sud, possiede il gene prepotente della curiosità. Copywriter di professione, storyteller per vocazione, vegetariana per scelta, nel tempo libero fa esperimenti ai fornelli e acquista più libri di quanti potrà mai leggerne.